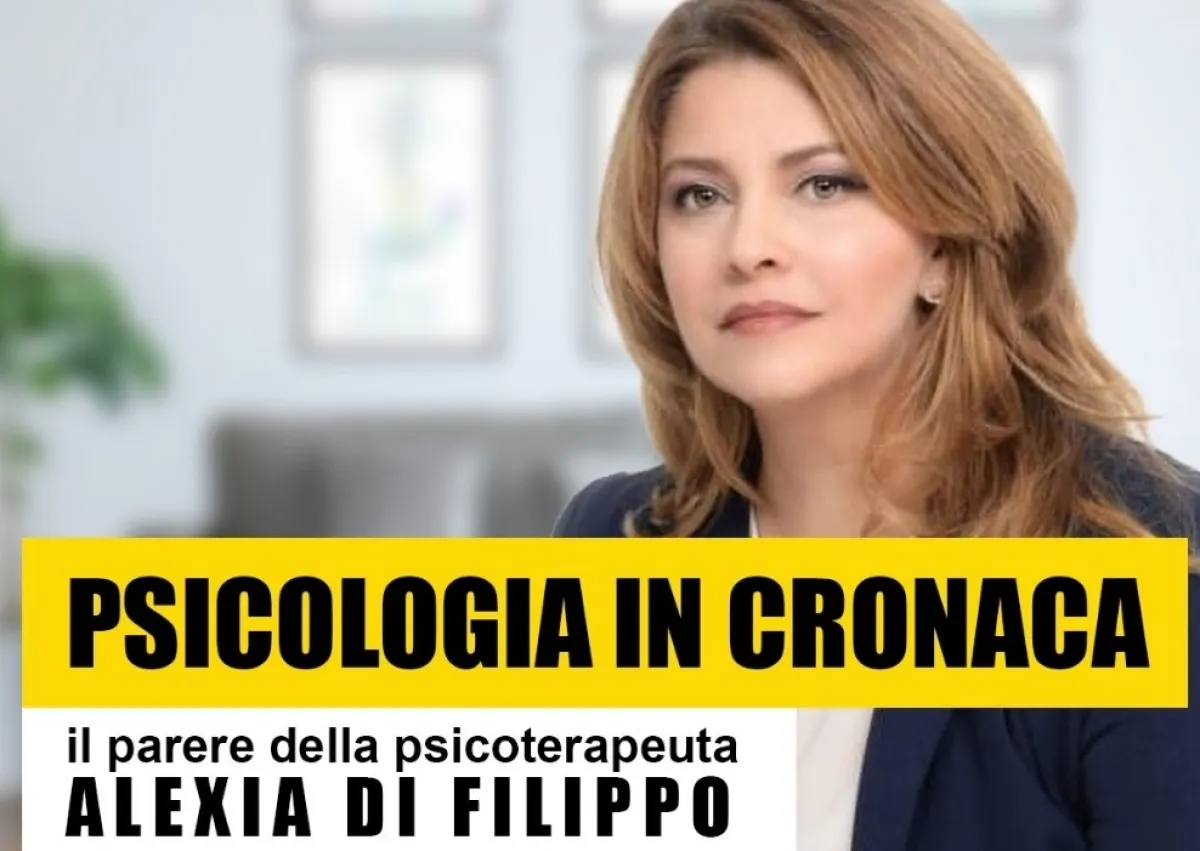
“È successo ancora”, è l’incipit col quale solitamente apro i miei contenuti in tema di femminicidio, affinché sia chiara la reiterazione di una aberrazione che appare inarrestabile perché non compresa correttamente e pertanto non affrontata, ma soprattutto prevenuta, con i giusti strumenti.
Malgrado il mio impegno storico e costante nel rappresentare la necessità e l’urgenza di un cambiamento culturale, che avrebbe richiesto misure educative da disporre nelle scuole, mi sono trovata, ci siamo trovati, in questi giorni, a contare due nuove vittime: due ragazze di soli 22 anni, Ilaria Sula e Sara Campanella, uccise peraltro con una efferatezza e crudeltà raccapriccianti. Due preziose esistenze rubate alla vita, come fiori strappati alla terra.
Circa le cause della violenza di genere e del suo atto culminante e tragico del femminicidio, di cui si è abbassata pericolosamente l’età di vittime ed autori, ho scritto approfonditamente in diversi articoli.
Qui vorrei focalizzarmi sulla debacle educativa alla base di questa emergenza perenne. È infatti evidente che gli stereotipi di genere, espressione di un pensiero retrivo di origine patriarcale cui aderisce quasi un italiano su due (ISTAT, 2023), siano stati trasmessi anche ai più giovani (Save the Children, 2024).
Ciò in parte spiega la ragione per cui tanti, troppi ragazzi percepiscano la persona di sesso femminile come inferiore a loro e da considerare al pari di un oggetto di proprietà e/o del desiderio alla quale non viene riconosciuta la facoltà di autodeterminarsi, ma soprattutto di dirgli di no.
L’altra criticità è rappresentata dagli stili educativi inappropriati adottati dai genitori, tipicamente quelli iperprotettivo e permissivo, che sovente consolidano problematiche conseguenti a legami di attaccamento perturbati, determinando la crescita di ragazzi sprovvisti di senso del limite, della responsabilità delle proprie azioni, nonché fortemente intolleranti alla frustrazione.
Una ulteriore tendenza drammatica, sotto gli occhi di tutti, è quella di occuparsi dei figli soprattutto sul piano materiale, lasciandoli in una condizione al limitare dell'abbandono educativo ed in uno stato di immersione senza controllo nel virtuale, dove sono esposti alla pornografia in età precoce, a contenuti esplicitamente violenti e a narrazioni di odio contro la donna provenienti da teorie suprematiste maschili come quella degli Incel.
Va inoltre tenuto conto delle famiglie monogenitoriali in crescente aumento e che costituiscono circa il 20% del totale, per cui il genitore affidatario, tipicamente la madre, è sovente in affanno nell’adempiere efficacemente alla mission educativa anche perché, spesso, non adeguatamente sostenuta dall’altro genitore.
E qui giungiamo al nodo gordiano, quello dell’esempio del padre, figura di identificazione diretta per bambini e ragazzi, depositaria e garante della regola, che dovrebbe occuparsi dell'iniziazione alla mascolinità del figlio impartendogli la prima educazione all'affettività.
Dopo il ‘68 si è assistito all’eclissi della figura paterna che ha perso i caratteri dell’autoritarismo precedente ma non ha ancora elaborato una identità convincente che sappia declinare la forza in assertività, l’assenza in riferimento autorevole, l’arbitrio in limite e contenimento.
Come si può diffusamente osservare, tanti padri disattendono all’impegno educativo o disinteressandosene, o ricoprendo il ruolo di amici, creando una complicità anomica deleteria.
O ancora, se separati/divorziati, coinvolgendosi in una girandola di relazioni tossiche, rappresentando così un esempio dannoso di come si gestisce manipolativamente il rapporto con l’altro sesso, trasmettendo il più delle volte una visione della donna reificata e stereotipica.
È per questo che ritengo fondamentale l'educazione affettiva nelle scuole ed estremamente utili i corsi a sostegno della genitorialità, poiché molti genitori non sono in grado o nelle possibilità di seguire i figli, evidenza che emerge da tanti indicatori e soprattutto dai fatti drammatici che continuano a susseguirsi.
Naturalmente anche le madri hanno le loro responsabilità nel desiderare figli maschi con attesa messianica, crescendoli nella venerazione, non esitando poi a giustificarli e ad aiutarli, deresponsabilizzandoli, anche di fronte a fatti gravi e gravissimi, come la cronaca ci ha mostrato in diverse occasioni.
Tuttavia, centrale è la necessità che si affermi e prevalga una nuova figura di padre che esprima un maschile alternativo a quello considerato vincente e a cui fin troppi ragazzi si ispirano, legato alla forza muscolare o alla manipolazione, alla furbizia, alla prevaricazione e alla prepotenza.
Per questo è importante che un uomo dia ai figli l'esempio di un rapporto rispettoso con la madre e di un accudimento nei loro confronti amorevole, emotivamente valido ed autorevole, che sia tenero ed al contempo saldo, aperto ma credibile.
Ciò al fine di iniziarli ad una mascolinità affettiva, educandoli alle emozioni, all'importanza della libertà di scelta dell'altro, come della propria, della necessità del consenso, della gestione della frustrazione e dell’accettazione di un NO che si attua anche dicendoglielo durante la crescita, facendogli quindi assumere le responsabilità delle loro azioni fin da piccoli.
In tal modo il maschile fragile, senza volto, descritto dal prof. Alexander Mitscherlich, in “Verso una società senza padre” nel 1970, che è poi quello che oggi, manipola, aggredisce e/o uccide, può finalmente evolversi incarnando un uomo nuovo che mostri la sua forza nella solidità valoriale, nella profondità affettiva e nella capacità educativa.